Ciao e buon sabato!
Questa è l’uscita 85 di S’È DESTRA, la newsletter che racconta fatti e idee delle destre in Italia e nel mondo. La scrivo io, che sono Valerio Renzi, in collaborazione con Fandango Libri, e con una certa dose di approssimazione viene inviata una volta a settimana il sabato.
Intanto una notizia: il 6 giugno esce in libreria Le radici profonde. La destra italiana e la questione culturale, il mio nuovo libro. Ecco la copertina (bella vero?):
Oggi un dialogo con Alberto Toscano a partire dal suo libro Tardo fascismo. Le radici razziste delle destre al potere edito da DeriveApprodi. Toscano insegna alla Simon Fraser University e co-dirige il Centre for Philosophy and Critical Theory alla Goldsmiths dell’University of London. Il suo ultimo lavoro ha il pregio di non limitarsi a descrivere il successo dell’estrema destra globale, né di limitarsi a uno sforzo definitorio del “nuovo fascismo”, ma prova descriverne l’operatività aprendo molte tracce di lavoro, utilizzando il materiale proveniente dal marxismo nero, dalla critica decoloniale e dall’antifascismo del Dopoguerra.
Per non perderci di vista online: la mia mail è valrenzi@gmail.com, ho un profilo su X e uno su Instagram, su Bluesky e Mastodon. S’È DESTRA è anche un canale Telegram per tutte le cose che non stanno in una newsletter settimanale.
Domani ci possiamo incontrare a Roma al Festival Rossa Primavera, insieme a Ilaria Cucchi e altri ospiti.
Ora iniziamo!
Il tuo lavoro ha il pregio di interrogarci su tema del fascismo, del suo ritorno o della sua permanenza, provando ad andare alla radice delle cose e non limitandosi a raccoglierne i sintomi e a descriverli, avanzando delle tesi da discutere. Spesso il "ritorno del fascismo" in questi anni è stato pensato sempre come risposta alla crisi economica, e abbiamo cercato ovunque i segni del tempo di Weimar. Tu ci solleciti invece ad utilizzare il materiale che la storia ci mette a disposizione, non rinunciando alle analogie, ma invitandoci anche a riflettere sulla temporalità in materia diversa utilizzando ad esempio il pensiero dell'antifascismo del radicalismo nero. In questo senso mi sembra molto pertinente l'idea che per qualcuno il fascismo nella nostra società non è una possibilità a venire, ma una realtà vissuta sulla pelle. Come si crea allora una coalizione tra chi vive condizioni così diverse?
L'esperienza differenziale del fascismo, che fa sì che certi soggetti vivano condizioni di dominazione spietata e un vuoto sostanziale di diritti in società che continuano a considerarsi liberali e strutturate come stati di diritto, è un’intuizione fondamentale, come suggerisci, del pensiero antifascista che scaturisce dal radicalismo nero e dalle multiple tradizioni del pensiero anticoloniale (e pure di correnti di critica femminista e queer aperte all’analisi del capitalismo razziale, e non chiuse in un orizzonte bianco ed eurocentrico). Ciononostante, come argomentato sia da W.E.B. Du Bois che George Padmore negli anni ’30, o da Angela Davis nei ’70, questa realtà non significa che abbiamo a che fare con compartimenti stagni. Sebbene lo stato razziale sia un doppio stato – nel senso definito dal giurista Ernst Fraenkel nella sua analisi della Germania nazista (Der Doppelstaat, 1941; trad. it. 1983: Il doppio stato), uno stato “normativo” per certi individui e gruppi (“ariani”) e “discrezionale” o “arbitrario” per altri (ebrei, disabili, Rom, comunisti, slavi, colonizzati, ecc.) – vi è quasi sempre una certa porosità tra queste categorie (anche se dobbiamo riconoscere situazioni nelle quali le premesse per una qualsiasi solidarietà sono infime o effettivamente nulle, da Jim Crow negli Stati Uniti fino al regime di apartheid, pulizia etnica e sterminio in Israele/Palestina oggi). Evidentemente, anche in condizioni meno estreme, dove si possono individuare interessi “oggettivi” in comune che trascendono differenze razziali, di genere o status, il problema coalizionale rimane squisitamente politico, scevro di qualsiasi garanzia. È comune argomentare che regimi autoritari o fascisti sono quasi sempre presi in una dinamica repressiva espansiva ed acceleratoria, e che il riconoscimento di questa traiettoria potenziale è il primo passo nella costituzione di un “fronte” antifascista. Emblematico qui è il citatissimo sermone ammonitorio di Martin Niemöller: “Prima vennero a prendere i comunisti, e io non dissi nulla, perché non ero comunista … Poi vennero a prendere me, e non era rimasto più nessuno che potesse parlare in mia difesa.” Vale la pena riflettere su come questa parabola (che può transitare attraversare identità razziali, politiche, sessuali e così via) registra il rovescio del riconoscimento di una esperienza differenziale del fascismo, una seppure ansiosa convinzione soggettiva di “immunità”, ma anche una scommessa che forse il meccanismo si fermerà prima di raggiungermi. E sarebbe ingenuo negare che spesso la scommessa ha funzionato. Ora, certe accelerazioni repressive – come quella che possiamo testimoniare oggi negli USA, dove arresti e deportazioni di residenti e studenti stranieri per dissenso contro il sostegno del governo al genocidio dei palestinesi, o per supposta partecipazione a gang “terroristici” sudamericani colpevoli di una fantomatica “invasione” degli Stati Uniti, stanno colpendo anche cittadini – possono creare le condizioni per alleanze politiche, partendo dal riconoscimento di una precarietà compartita. Ma credo non sia sufficiente cercare di persuadere coloro che godono di un “privilegio” relativo (spesso quello dei penultimi della terra in contrasto agli ultimi, sovente accompagnato da un salario più psicologico che reale) che un’ulteriore fascistizzazione li metta pure loro al repentaglio. Le coalizioni difensive sono più labili che quelle alleanze che propongono progetti di vita ed emancipazione comuni – penso a mobilitazioni lavorative e sindacali che rifiutano la distinzione tra lavoratori “nazionali” e stranieri, o, in California, il tipo di alleanze contro l’espansione del sistema carcerario che hanno creato movimenti di resistenza comune tra comunità rurali bianche impattate dalle nuove carceri e le madri di colore di giovani presi dentro il sistema penale (si vedano i lavori di Ruth Wilson Gilmore).
Tornando alle analogie storiche. La vittoria di Donald Trump sembra aver messo il nostro tempo su un piano inclinato. Dopo anni in cui sembrava che non cambiasse mai nulla, oggi sembra che ci troviamo in un flusso accelerato di eventi. Più che l'avvento del nazismo o del fascismo però, il rapporto Trump-Musk forse ci porta però in un tempo ancora anteriore: l'età moderna dei monopoli privati garantiti dalla forza dello Stato lungo le rotte commerciali. Il fascismo in questo contesto interverrebbe a ridurre le funzioni dello Stato al nocciolo duro dell'utilizzo della violenza e al mantenimento dell'ordine, mentre l'iniziativa privata viene garantita grazie alla legislazione ma anche ai finanziamenti pubblici, come nel caso di Starlink. Cosa ne pensi?
Innanzitutto, mi pare che uno degli effetti principali di questa seconda amministrazione Trump, in particolare dell’uso incontrollato e spettacolarizzato del meccanismo degli executive orders, sia una difficoltà nel discriminare durevoli trasformazioni o eventi significativi da pseudo-eventi, simulacri e distrazioni. Quest’effetto di saturazione e shock desensibilizzante è voluto (Russell Vought, uno degli artefici chiave della politica trumpiana, annunciò ancor prima delle elezioni la volontà di “traumatizzare” gli impiegati dello stato federale, colpevoli di complicità in un silenzioso e strisciante coup d’état cripto-marxista). Detto questo, credo che tu abbia ragione nel segnalare la centralità nel nostro ciclo politico reazionario di un legame tra capacità (e violenza) statale e monopolio privato, che trova il suo emblema più estremo nell’embrionica e volubile diarchia di Musk-Trump. Altrove, ho cercato di analizzare questo fenomeno come un cesarismo mutante che trae le estreme conseguenze sia della concentrazione del potere politico in una sovranità decisionale personalizzata (prodotto in particolare della normalizzazione dello stato d’eccezione nel contesto della “guerra al terrore” post 9/11), sia della personalizzazione ed iper-concentrazione del potere economico in un tardo neoliberismo incentrato su Silicon Valley. Come ho rammentato nel libro, è pur vero che il primo fascismo in Italia – basta vedere i discorsi di Mussolini prima della Marcia su Roma – si presenta come l’avanguardia violenta ed organizzata, sociale e politica di un iper-liberismo economico, uno squadrismo che ha come stella polare lo stato “Manchesteriano”. Non dobbiamo dunque identificare fascismo con uno statalismo “totalitario”, e dobbiamo rimanere sensibili a come le ideologie, passioni e programmi politici possono essere sovradeterminati da congiunture politico-economiche – in questo senso l’abbandono dell’iper-liberismo all’interno del fascismo stesso riflette pure la necessità di politiche industriali, equilibri di classe ed assetti geopolitici profondamente diversi dalla nostra congiuntura contemporanea. In questo senso, l’estrema finanziarizzazione, diseguaglianza e concentrazione di ricchezza che caratterizza il capitalismo contemporaneo – il tutto accompagnato dall’estreme debolezza di movimenti rivendicativi a fondo economico, che siano movimenti sindacali, popolari o dei “poveri” (poor people’s movements, nel senso di Frances Fox Piven) – rende possibile una certa ripetizione di quella visione iper-liberista del primo fascismo, l’uso della pubblica violenza per difendere, agevolare ed intensificare l’accumulazione privata. Il piano inclinato ci ha pure portati ad una grottesca indistinzione del potere economico e del potere politico: Trump usa il suo potere presidenziale direttamente come fonte di lucro (che sia con le sue varie cripto-monete o con viaggi ufficiali al Golfo collegati agli enormi investimenti immobiliari della Trump Organisation nella zona); mentre, come abbiamo visto in Ucraina, la ricchezza stratosferica di Musk, ma soprattutto il suo controllo sul sistema satellitare Starlink, gli permettono di operare come un meta- o mega-sovrano.
Nel tuo libro affronti l'idea del fascismo non solo come modello di accentramento della violenza quanto di un potere totalitario esercitato dall'alto verso il basso in modo rigidamente pianificata, ma affronti l'idea del fascismo come modello politico che delega (con relativa autonomia) l'esercizio del potere e della violenza ad alcuni soggetti determinati in termini sessuali e razziali. Il fascismo redistribuisce così porzioni di potere e non welfare. È così che anche oggi si assicura il proprio consenso? Offrendo al proprio elettorato popolare non posti di lavoro o migliori condizioni di vita ma la garanzia di poter esercitare (direttamente o indirettamente) un potere su altre porzioni di popolazione?
Questo fenomeno della delega e partecipazione nel potere e nella violenza statale opera sia a livello materiale che in una dimensione psicologica o fantasmatica, e ci permette di riconoscere i profondi legami tra la produzione di soggettività fascista e le sue controparti nella lunga storia del colonialismo (basta pensare alla figura del colono sionista nei territori occupati palestinesi, punta di lancia o avanguardia della spoliazione coloniale e “libero di dominare” con impunità). Come fece notare Foucault, non è un caso che il fascismo trovi così tanti dei suoi seguaci e sostenitori tra gli specialisti della violenza statale (polizia, esercito, secondini, ecc.). Questa capacità di esercitare in pratica o fantasia un potere, e forse una violenza, su quelli che vengono definiti come altri, nemici, minacce, parassiti, stranieri, alieni, ecc. è certamente un ingrediente importante nella capacità del fascismo di generare consenso, di fare corpo. Quanto durevole sia questa promessa di supremazia e privilegio rimane una questione aperta alle contingenze della politica. Quando la partecipazione a un progetto identitario-repressivo – come quello delle deportazioni di massa di lavoratori immigrati senza permessi di soggiorno, per esempio – non porta con sé nessun meccanismo di redistribuzione o miglioramento materiale per i propri seguaci (cosa che il fascismo e nazismo storico fino a un certo punto fecero), al di fuori di condizioni di guerra non so se un consenso elettorale possa essere assicurato a lungo termine.
Credo che l'estrema destra abbia scelto, all'interno delle nostre società di eleggere ad avversario un certo tipo di soggetti sociali. Si tratta di quella larga e stratificata classe di precari del terziario avanzato, la cui vita è caratterizzata da bassi salari e alti titoli di studio, fortemente urbanizzata e con un'alta mobilità. È a questa classe disomogenea e sradicata cui la destra mi sembra stia attribuendo le stesse caratteristiche che durante l'affaire Dreyfus venivano attribuite ai Dreyfusardi. Per tornare a costruire analogie con il materiale che abbiamo a disposizione, altrove ho sostenuto che esiste un antisemitismo in assenza di ebrei, ovvero credo sia necessario costruire un'archeologia di come il materiale dell'antisemitismo di Età Moderna viene impiegato contro altri nemici della nazione...
Mi sembra un suggerimento promettente, ma aggiungerei che è essenziale per il nostro tardo fascismo (ma pure, in maniera diversa, nel fascismo storico) che il razzismo politico riesca ad articolare sia le “élite” sia le “classi pericolose”, la feccia, i “lumpen”, lo straniero, ecc. (nel nazismo, il banchiere ebreo assimilato e l’ebreo povero ed ortodosso dello shtetl orientale). Prendiamo l’idea della Grande Sostituzione, così cara a Meloni, Salvini, Orbán, Trump, ecc. – si basa sulla visione complottistica di un’alleanza tra élite (qui spesso l’antisemitismo è palese, vedi l’ossessione con Soros) e le masse di migranti di colore. Allo stesso modo, l’astio verso i portatori accademici dell’ideologia “woke” è basato sull’idea che stanno minando dall’interno le basi tradizionali del potere e dell’identità nazionali (del cittadino e produttore maschio, bianco ed etero), e, a mo’ di cavallo di Troia, permettendo l’“invasione” dello stato e le istituzioni da parte di soggetti impropri ed impuri (neri, migranti, trans, ecc.). È certo che inventarsi una pseudo-élite come capro espiatorio è una soluzione geniale, in quanto incanala negatività e risentimenti sociali permettendo ai veri detentori del potere economico, sociale e politico di identificarsi con il “popolo”; ma credo non dobbiamo scordarci che, in quanto politica che ha al suo cuore elettorale la paura della perdita, del declassamento, della precarietà da parte di ceti medi senza futuro, il fascismo deve plasmare figure del nemico sia in alto che in basso, nel cuore dello stato e fuori dai confini, preferibilmente articolando queste due polarità (cosa che la Grande Sostituzione fa perfettamente).
Insisti nel tuo libro su come il tardo fascismo sia stato in grado nell'ultimo ciclo politico elettorale di egemonizzare il conservatorismo, proponendosi come reazione preventiva alle spinte di cambiamento, e come dispositivo politico in grado di rafforzare le disuguaglianze sulle linee di classe, della razza e anche del genere. Questo ciclo potrebbe rappresentare l'ultimo tentativo di difendere un mondo che non esiste però più? Ormai su temi come il cambiamento climatico e i diritti civili, quanto è possibile davvero tornare indietro? Oppure il regime di guerra cambierà tutto?
Poni molto bene l’enigma della nostra congiuntura politica. Fino a che punto, per parafrasare Du Bois, l’aumento del salario psicologico (violenza retorica e repressione spettacolare dell’altro, accanimento giuridico contro i diritti civili e sociali di “minoranze” razziali, sessuali o politiche) può compensare la stagnazione o contrazione dei salari materiali? Quando (e non se) scoppieranno antagonismi sociali come quelli che ebbero luogo sulla scia dell’ultima crisi finanziaria e delle sue conseguenze a lungo termine (Occupy, indignados, “Primavera Araba”, George Floyd Uprising, ecc.), come si rapporteranno all’ulteriore concentrazione di potere economico e politico, al nostro neo-cesarismo? Non credo ci siano limiti a priori alla regressione giuridica e sociale – è evidente che molti intellettuali “organici” delle destre contemporanee hanno visioni del futuro apertamente neo-feudali, anti-democratiche, che prospettano forme di apartheid globale e un annullamento più o meno totale delle vittorie emancipatorie dell’ottocento e novecento – e che, da Trump a Modi, da Netanyahu e Orbán, vi sia un tentativo globale e sistematico di cancellare i risultati delle lotte anti-coloniali, sindacali, femministe, socialiste ed ecologiche. D’altro canto, non credo che la “mobilitazione totale” sia sociologicamente o ideologicamente (o, per altro, materialmente) una soluzione agibile per una fuga in avanti fascista (fuori dall’Israele e la Russia, o, parzialmente, l’India). La destra estrema “atlantica” non credo sia capace di richiedere grandi sacrifici o disciplina, persino in “regime di guerra” (da notare pure che in gran parte il tardo fascismo è si violento, persino sadico e crudele, ma non precisamente guerrafondaio, posizione poco spendibile in campo elettorale). Il problema rimane quello di creare coalizioni sociali e forze politiche popolari che possano intervenire quando si paleseranno ulteriormente i limiti della destra estrema elettorale, anticipando e bloccando, o prevenendo, ulteriori accelerazioni autoritarie. Per parafrasare Rosa Luxemburg, la barbarie è già qui, il socialismo non ancora.


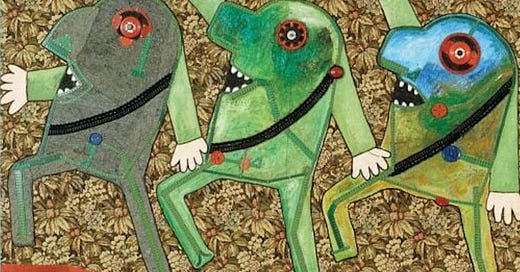






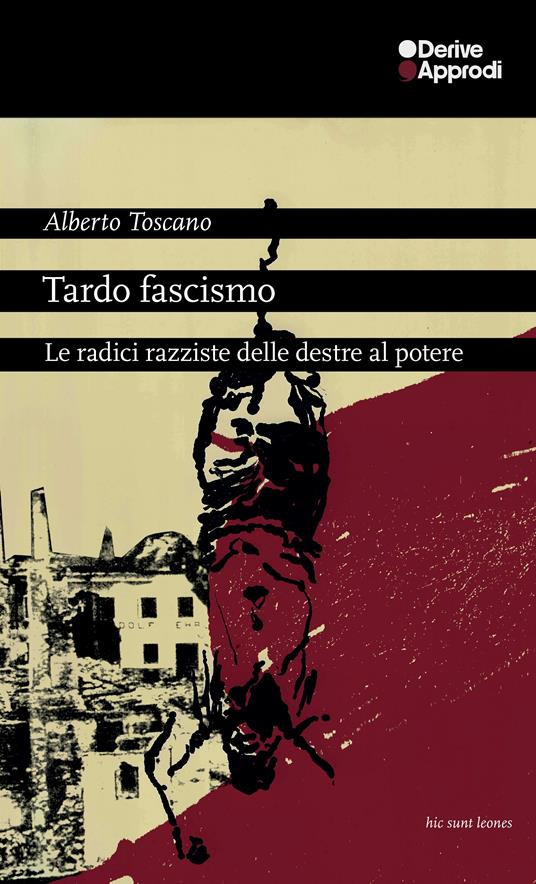

Mio cognato è convinto che la barbarie abbia da sempre covato sotto le ceneri del socialismo.
Per questo, dice lui, ci vorrebbe un bel secchio d'acqua.